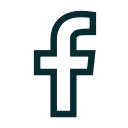Lui mi chiede: “Papà come faccio a raccontare ai miei compagni che la partita di oggi è stata arbitrata da una ragazza? Posso dire un’arbitra?”. Esordisce così, di domenica mattina, mentre io ancora con un occhio chiuso e uno aperto mi convinco che una risposta posso dargliela; giusta o sbagliata che sia, gli ho detto la mia. Che poi la risposta me l’ha suggerita la mia collega Clara in una mail di qualche giorno fa in cui mi suggeriva di leggere un articolo pubblicato sul sito dell’Accademia della Crusca.
Mio figlio che ha 9 anni vuole sapere perché non si può dire arbitra e la risposta a me pare evidente: il linguaggio con cui ci esprimiamo è chiaramente orientato, secondo me, verso il mondo maschile in quanto comunemente riconosciuto come “giusto”, a discapito di quello femminile che invece deve necessariamente adattarsi. E siccome parliamo anche di grammatica lui, mio figlio, anche se volesse non potrebbe utilizzare certi termini, pena la correzione con il rosso. Quindi niente assessora, arbitra o ministra perché la convenzione non lo prevede.
C’è un’ingiustizia di fondo di cui neanche le donne sembrano accorgersi. Anzi in molte ambiscono al ruolo prettamente maschile e quasi si alterano se provi a spiegargli che un’ingiustizia c’è. Qui subentra il complesso di inferiorità a cui l’uomo le ha costrette.
Sono convinto che questo argomento non avrebbe alcuna importanza se non ci fosse quest’ingiustizia di fondo, come non lo sarebbero le quote rosa che sono invece la rappresentazione palese del fallimento della nostra società dove l’uomo esercita la propria supremazia.
E allora perché non ministra, ingegnera o assessora? Perché non insegnare che la parità tra gli uomini e le donne passa anche attraverso il linguaggio? Perché non insegnarlo dai primi anni di scuola?
Forse sono un inguaribile romantico, ma non sarebbe poi così male anche perché mi chiedo: esattamente, cosa toglie alla lingua?