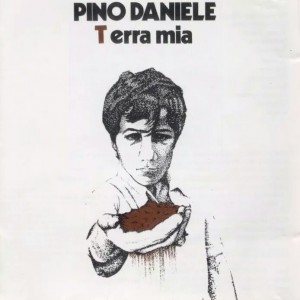Dai social network non si prescinde. Eppure bisogna fare più attenzione di quanto non si creda.
Dai social network non si prescinde. Eppure bisogna fare più attenzione di quanto non si creda.
Nei giorni scorsi i Nobraino, band italiana dal discreto seguito di critica e pubblico, scrive su facebook uno status (piuttosto infelice) dopo la tragedia del mare che è costata la vita a 800 persone a largo della Libia.
“Avviso ai pescatori: stanno abbondantemente pasturando il Canale di Sicilia, si prevede che quelle acque saranno molto pescose questa estate”
La rete, per usare un eufemismo, non la prende bene, e in poche ore la loro bacheca si infiamma di commenti violenti, accuse, minacce, parole al veleno.
Arriva il tweet di Roy Paci, direttore artistico del Primo Maggio di Taranto, che senza troppi giri di parole, invita i Nobraino, previsti in cartellone, a non presentarsi alla rassegna. Così come tanti altri, organizzatori di eventi e gestori di locali, che scaricano la band. Poche parole su un social network, che rischiano di costare caro.
Il post incriminato tuttavia, era accompagnato da un link del blog Diritti e Frontiere che si batte per la tutela dei richiedenti asilo e dei diritti dei migranti. Lo stesso Nestor Fabbri, chitarrista dei Nobraino e autore del post contestato, si occupa da anni di protezione internazionale dei diritti umani, ed ha lavorato per alcune Ong.
La frase dunque, andrebbe contestualizzata. Rimane sì una uscita poco felice e di dubbio gusto (quella che Daniele Luttazzi definirebbe “satira fascistoide”, perchè dileggia le vittime e non i carnefici) ma non trasforma i Nobraino in dei cinici razzisti.
Il linciaggio mediatico subito dalla band però mette in luce alcuni aspetti chiave della comunicazione di oggi: da un lato la necessità, quasi viscerale, di esprimere la propria opinione, figlia di un protagonismo da palcoscenico virtuale. Dall’altra, la scarsa attenzione alla realtà dei fatti: si legge poco e male, non si approfondisce, ci si ferma ai titoli e ci si forma un’opinione del tutto distorta.
Due aspetti che vanno di pari passo e che caratterizzano, in negativo, la realtà dei social media ed inquinano il dibattito sociale e politico su temi sensibili.
Sul primo punto, quello della necessità di esprimersi a tutti i costi, è evidente che ormai libertà di parola e libertà di offesa viaggiano su binari paralleli. Su qualsiasi contenuto, di qualsiasi argomento, troviamo tutto e il contrario di tutto. I commenti degli utenti diventano uno spazio di confusione intellettuale dove l’offesa verso il prossimo è sempre in agguato e porta a spirali infinite di polemiche virtuali.
In molti casi, osserva re il comportamento delle persone sul web significa ascoltare la pancia dei nostri concittadini. Senza censure, gli utenti della rete danno spesso sfogo a sentimenti reconditi che probabilmente non riescono ad esprimere con la stessa veemenza nella vita vera.
re il comportamento delle persone sul web significa ascoltare la pancia dei nostri concittadini. Senza censure, gli utenti della rete danno spesso sfogo a sentimenti reconditi che probabilmente non riescono ad esprimere con la stessa veemenza nella vita vera.
Fino a chiedersi se ha davvero senso scrivere un commento su un sito web: sommare la propria voce ad uno schiamazzo così forte da risultare indistinto.
Un esempio pratico lo si può incontrare scorrendo i commenti della pagina facebook di Gianni Morandi, dopo la pubblicazione di un messaggio di solidarietà alle vittime del naufragio.
Persino il povero Gianni, figura rassicurante per eccellenza, e che ha fatto della sua pagina facebook uno spazio di incontro e di confronto, non viene risparmiato da una valanga di commenti razzisti e xenofobi, a cui nonostante tutto, cerca di rispondere con gentilezza e cortesia, per quanto possibile.
La piazza virtuale aperta dai nuovi mezzi di comunicazione rivela strade potenzialmente sterminate, ma anche disseminate di buche dentro cui è facile cadere. Le parole hanno un peso che può trascinare a fondo: lo sanno bene i Nobraino, così come lo sa Fabio Tortosa, il poliziotto che su facebook ha rivendicato l’assalto alla scuola Diaz di Genova nel 2001. Lo sanno bene i politici (Santanchè e Gasparri e le gaffe su twitter) e i personaggi pubblici (Paola Saluzzi e il tweet infelice contro il pilota di Formula 1 Fernando Alonso).
Il secondo aspetto, quello dell’approssimazione e della disattenzione ai contenuti, sembra essere una caratteristica propria del mondo moderno: siamo la generazione con il maggiore accesso ai mezzi di comunicazione di tutte le precedenti, ma la cascata di informazioni che riceviamo quotidianamente non ci rende più consapevoli o più informati.
All’indomani della tragedia di Charlie Hebdo, Andrea Alicandro si è divertito a provocare il popolo della rete con un articolo sul sito de Il Manifesto dal titolo “Sconcertante: la strage di Parigi provocata dalle scie chimiche, qui le prove”, e con uno, qualche giorno dopo che si intitolava “Incredibile: guardate cosa succede sul blog di Grillo”. I titoli volutamente accattivanti non avevano alcuna attinenza con i pezzi di Alicandro, ma l’esperimento è servito a dimostrare una amara verità: sul web non si approfondisce e spesso ci si ferma alle prime parole. E il giornalismo di oggi, è schiavo dei titoli “acchiappa-clic”.
Il risultato è stato abbastanza paradossale: gli utenti facebook “amici” del Manifesto, un target ben definito ideologicamente, ha espresso il proprio disappunto a suon di commenti inorriditi per il fatto che il loro giornale preferito avallasse le tesi dei complottisti, collegando Charlie Hebdo alle scie chimiche.
Del resto, si tratta dello stesso meccanismo che muove operazioni editoriali come Lercio, sito di notizie volutamente false spesso amplificate da facebook, grazie al sistema dei titoli-esca. Nel 2013, per esempio, furono in molti a commentare inorriditi la notizia-bufala del gattino gonfiato col compressore in un campo rom.
Quello che resta è un’amara constatazione: il web ci ha proiettato verso il futuro mettendoci il mondo a disposizione, ma se non abbiamo la pazienza di acchiapparlo ci sfugge da tutte le parti, lasciandoci l’impressione di aver visto tutto senza averci capito niente.

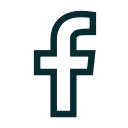





 re il comportamento delle persone sul web significa ascoltare la pancia dei nostri concittadini. Senza censure, gli utenti della rete danno spesso sfogo a sentimenti reconditi che probabilmente non riescono ad esprimere con la stessa veemenza nella vita vera.
re il comportamento delle persone sul web significa ascoltare la pancia dei nostri concittadini. Senza censure, gli utenti della rete danno spesso sfogo a sentimenti reconditi che probabilmente non riescono ad esprimere con la stessa veemenza nella vita vera.